Sezione Locale della Società Psicoanalitica Italiana
Sezione Locale della Società Psicoanalitica Italiana
*Per citare questo articolo:
Gonella V., (2024) “Break on through (to the other side). Il disco d’esordio: processo di soggettivazione di una rockstar”, Rivista KnotGarden 2024/1, Centro Veneto di Psicoanalisi, p. 148-180
♫ The Doors, “Break on Through” (1967)
di Vittorio Gonella
(Cuneo), Membro della Società Italiana di Psicoanalisi e Psicoterapia – Sándor Ferenczi
Per una lettura più agile e per ulteriori riferimenti di pagina si consiglia di scaricare la Rivista in formato PDF.
“Su noi profani ha sempre esercitato
una straordinaria attrazione il problema di sapere
donde quella personalità ben strana
che è il poeta tragga la propria materia”
(Freud, 1907, 375)
Sul finire del breve scritto Il poeta e la fantasia – da cui è tratta la citazione – Freud propone l’ipotesi che la passione umana per la poesia risieda nel fatto che “il poeta ci mette in condizione di gustare d’ora in poi le nostre fantasie senza alcun rimprovero e vergogna” (Freud, 1907, 383).
Questo scritto freudiano mi sembra rappresentare bene il rapporto che le persone hanno instaurato, nel corso di questi decenni, con la musica rock, ascoltando in essa qualcosa che evocava le proprie esperienze e i propri vissuti personali grazie al talento tenebroso e inafferrabile dell’artista; a mio parere, questo tipo di approccio ha impedito all’ascoltatore di riconoscere che l’esperienza interiore della rockstar è l’autentico motore della sua produzione artistica, a partire, in particolare, da un periodo in cui questo accadrà sempre più spesso.
Ci fu, infatti, un momento nella storia del rock – corrispondente agli anni della sua adolescenza, nella seconda metà degli anni Sessanta – in cui, agli assoli di chitarra elettrica e alle sezioni ritmiche tambureggianti, si aggiunsero poesia e melodia, lacrime e dolore, rabbia e sofferenza, canto intimo e non solo urlo, grazie al grande contributo personale che l’autore trasforma in atto creativo stampato sul vinile.
Il rock è uno stile musicale giovane: la sua vita inizia nei primi anni Cinquanta, quando ormai il blues e il folk – che lo ispirarono – e il jazz avevano già una loro storia alle spalle; e ha anche una vita marginale nella letteratura psicoanalitica: una ricerca nei Pep Archive[1] evidenzia come la musica rock sia citata in pochi articoli e spesso all’interno della presentazione di materiale clinico portato in seduta dai pazienti; e come sia stata poi, in alcuni di questi articoli, osservata come fenomeno giovanile che offre spunti sul mondo intrapsichico e interpersonale degli ascoltatori adolescenti.
Vorrei qui parlarne dal punto di vista dell’autore-creatore, considerandolo una forma d’arte che, avvalendosi di una struttura emozionale non cognitiva, offre – come scrive lo psicoanalista britannico Kenneth Wright[2] – uno spazio di mentalizzazione e di condivisione di esperienze del sé, anche di quelle traumatiche.
Penso che per avvicinarsi alla musica rock come arte del soggettivo, sia necessario ascoltarla e interpretarla attraverso concetti psicoanalitici ancora sconosciuti a Sigmund Freud che, rispetto all’ascolto musicale, ammetteva: “una disposizione razionalistica si oppone in me a ch’io mi lasci commuovere senza sapere da che cosa” (Freud, 1914); parole più recenti come holding, sintonizzazione emotiva, sé, trauma, soggettivazione sono alcuni dei grimaldelli che ci offrono l’opportunità di guardare a quest’arte “attraverso il prisma della psicoanalisi” (Wright, 2022, 351), una grande opportunità per comprendere che cosa ci sia dietro la produzione musicale.
Il rock: da intrattenimento a manifesto a forma d’arte
“I miei dischi sono stati sempre molto soggettivi.
Soggettivi ma spero anche universali”
(Joni Mitchell)
Il rock and roll – questo il suo nome originario – nasce come musica che parla ai giovani: l’obiettivo è quello di offrire uno spazio di evasione, mentale e fisico, dove potersi lasciare andare, ballare, stare insieme, dando così voce a quelle spinte pulsionali e di differenziazione generazionale che la società adulta di quegli anni invitava a esprimere, per poi accorgersi in breve tempo che le risposte dei giovani non erano quelle gradite. E le prime rockstar rappresentano perfettamente tutto questo sul palco e nelle apparizioni televisive in prime time di fronte alle famiglie americane: performance dense di sensualità e seduttività in cui lo strumento musicale è un rappresentante simbolico pulsionale di grande impatto: pensiamo a Elvis Presley e alla sua chitarra o a Jerry Lee Lewis nel rapporto fisico con il suo pianoforte.
Con gli anni Sessanta, abbandonato il ‘roll’, la musica rock inizia anche a parlare degli adolescenti: “una via di espressione di sé come soggetti” (Carnevali C., 2015, 147) che diventa una colonna sonora dei loro desideri di cambiamento e della loro rabbia verso la società dei genitori: in questo senso, il rock è “un primo potente cortocircuito” (ibid., 148) che dà voce al malessere di un mondo giovanile che combatte i codici imposti fino ad allora, che aiuta le giovani generazioni a vivere e sognare, è il sottofondo di battaglie politiche e sociali, simbolo di libertà e non violenza. Gli inni e i cortei pacifisti non sono più un’esclusiva dei folk singer, come Woody Guthrie e il giovane Bob Dylan[3], ma molte rockstar partecipano e danno voce alle proteste contro la guerra in Vietnam e la segregazione razziale.
Sono gli anni in cui questo adolescente-rock inizia ad avvicinarsi ad altre arti – come la poesia e il cinema – con cui dialoga, riceve e offre spunti; attraverso i suoi protagonisti, inizia anche a girare il mondo, conoscendo altre culture e stili musicali con cui si sente pronto a collaborare e contaminarsi introducendo nei propri lavori strumenti e ritmi fino ad allora sconosciuti[4].
Il rock amplia i propri orizzonti e questo rende molto più vivo, e reciprocamente vitale, il dialogo con i giovani ascoltatori: non è più una comunicazione ‘one way’ ma musica che si mette in ascolto del mondo e dei suoi cambiamenti per trovare ispirazione e restituirla in musica; compaiono sul mercato veri e propri inni giovanili come My Generation[5] (1965) degli Who e (I can’t get no) Satisfaction[6] (1965) dei The Rolling Stones, perché artisti come Pete Townshend e il duo Mick Jagger – Keith Richards sentono la responsabilità – e l’opportunità – di dare voce all’energia dei giovani ascoltatori, che riconoscono nella rockstar qualcuno che li comprende e offre una potentissima cassa di risonanza al loro Zeitgeist generazionale[7].
Ma l’evoluzione di questo giovane genere musicale, in questi anni diventato anagraficamente adolescente, non si ferma: dopo la metà degli anni Sessanta, cantanti e musicisti iniziano a parlare e mettere in musica la loro personale realtà interna, la loro storia e i loro vissuti. Il disco a 33 giri, la cui durata varia tra i 30 e i 50 minuti, offre non solo la possibilità di condividere esplorazioni musicali ritenute in precedenza poco commercializzabili ma anche l’opportunità di portare nell’opera rock sé stessi e le proprie esperienze: il rock diventa un’arte simbolica che rispecchia la forma interiore del suo creatore “non come un semplice riflesso in un vetro” (Wright, 2022, 354) ma ri-creandola in una nuova forma, quella musicale.
Il percorso discografico dei Beatles ben esemplifica questi rapidi passaggi: se nei primi anni Sessanta dominavano le hit parade con Twist and Shout[8] (1963), pochi anni dopo regalavano all’umanità un inno universale come All you need is love[9] (1967), per poi pubblicare nel 1968 il doppio vinile omonimo – conosciuto come White Album – in cui sono presenti molte canzoni intime e personali come Julia, brano breve e commovente in cui John Lennon si rivolge alla madre, morta investita da un’auto quando il figlio aveva diciassette anni[10].
Il rock diventa così lo strumento con cui l’artista può parlare di sé, creando un legame ancor più profondo con gli adolescenti all’ascolto, che sentono – non solo più nel senso di to listen ma anche di to feel – che la rockstar si mette in gioco attraverso una creazione che veicola e trasmette molteplici stati affettivi del suo sé, grazie anche alla possibilità di utilizzare contemporaneamente il testo scritto, gli strumenti nella cornice musicale e la voce, con tutte le sue potenzialità espressive.
Il risultato sarà, come scrive Christopher Bollas a proposito della creatività artistica, un “oggetto che non esprime più semplicemente il sé, ma lo ri-forma” (Bollas, 1999, 217): assume grande valore la relazione tra opera e storia dell’artista in quanto i dati biografici vengono a rappresentare quei fatti scelti (Trabucco, 2007) che prendono forma, e sono proprio quelli che “a loro volta vanno a costituire il «fatto scelto» dell’opera, quell’elemento che finisce per accomunare l’autore e il fruitore dell’opera” (Trabucco, 2007, 674).
Grazie al valore creativo del rock molti artisti si prendono cura del loro mondo interno, raccontando la loro storia e le ferite subite nella mente e nel corpo; nel prendere una forma autentica che parla dell’artista – adesso contemporaneamente Soggetto e Oggetto del proprio lavoro – i contenuti si distribuiscono su un asse che va da opere in cui l’espressione artistica è il prodotto di un sé dinamico e coeso, a opere in cui sono le aree traumatiche a dare un’impronta decisiva; in entrambi i casi, questo movimento di insight crea quel corridoio interpsichico (Spagnolo, 2017) tra il sé della rockstar e quello di chi è disposto a un ascolto autentico, grazie al quale poter sentire anche sé stessi nel susseguirsi dei solchi del vinile.
L’espressione del proprio mondo interno non coincide sempre con l’elaborazione, che rimane legata alle capacità di rêverie; il disco ha una funzione di contenimento ma non può essere una mente supplementare che sostituisce le funzioni di mentalizzazione non acquisite e mancanti: questo aspetto è, a mio parere, ciò che differenzia le rockstar sopravvissute – anche grazie alla musica – a una storia di vita caratterizzata da esperienze traumatiche[11], da quelle che non ce l’hanno fatta, nonostante il sostegno temporaneamente trovato nell’arte.
Il disco d’esordio: tra ideale dell’Io e aree traumatiche
“La musica è un modo per catturare l’essenza di chi sono”
(Bruce Springsteen)
È in questo terzo ambito – l’opera rock come opera d’arte – che vorrei concentrare la seconda parte del mio lavoro, soffermandomi su alcuni dischi d’esordio che sono stati veri e propri documenti di presentazione della carriera successiva; opere prime che rappresentano una sorta di adolescenza artistica per le rockstar: quella fase evolutiva in cui l’identità dell’individuo prende una forma autentica e riconoscibile, dopo gli anni preadolescenziali fatti di messa in discussione, fatiche, timori, incapacità a decidere e legittimarsi.
L’infanzia e la preadolescenza musicale – di cui fa parte quella cronologica, nel senso che ogni rockstar ha avuto i suoi primi contatti con l’arte al più tardi in questo periodo della vita – sono costituite da quell’insieme di esperienze di vita e incontri con la musica ovviamente diversi per ogni individuo e che ne condizionano la crescita, riempiendo quel bagaglio mentale che in adolescenza verrà aperto, offrendo strumenti per la costruzione dell’identità.
Nei dischi d’esordio è possibile riconoscere ciò che sarà la carriera musicale adulta, che in quest’ottica inizia con il secondo album: i fili conduttori delle produzioni successive sono già presenti nel primo lavoro, a volte in forma meno esplicita e comprensibile, diventando più chiari nei lavori che lo seguiranno.
Penso spesso all’adolescenza come a un’ouverture, quelle composizioni musicali strumentali poste, ad esempio, all’inizio delle opere liriche[12] e che hanno la funzione di motivo guida: in esse vengono condensati i temi dell’opera, che verranno successivamente proposti e sviluppati in modo più approfondito. L’opera prima è l’ouverture della carriera, spesso contiene tematiche che la rockstar accenna ma deciderà di approfondire dopo molti anni e molti dischi.
Il disco d’esordio rappresenta perfettamente ciò che Giaconia afferma scrivendo che “gli ideali dell’adolescenza, pur nella loro mutevolezza rappresentativa, contengono i temi dominanti che si svilupperanno nel corso della vita; essi sono significati nell’ideale dell’Io” (Giaconia, 1997, 876); è quello spazio, quel momento, in cui tutto si gioca (Kestemberg, 1980), la sua bellezza sta proprio nell’essere adolescenziale, autentico e vitale, ribelle e perturbante, malinconico e onesto.
Tutto ciò che è stato preparato nell’infanzia (Kestemberg, 1980) – musicale ma non solo – dell’artista inizia a prendere una forma identitaria riconoscibile, spesso in modo veloce, immediato, poco curato in termini di suono e produzione, perché l’urgenza è quella di farsi sentire, di comunicare al mondo la propria presenza, proprio come un qualsiasi adolescente. E molti di essi rappresentano quel progetto che, secondo Chasseguet Smirgel (1975), è sempre presente dietro l’ideale dell’Io.
Nel titolo di questo paragrafo ho parlato di ideale dell’io e aree traumatiche perché è su questa direttrice che possiamo analizzare e comprendere molte di queste opere: a volte si tratta di una espressione originale e vitale del percorso di crescita e della formazione dell’ideale dell’Io adolescenziale necessario alla creazione di un sé coeso e autonomo; in altri casi il disco d’esordio, operando una funzione di holding, raccoglie e tenta di contenere le tracce traumatiche che l’espressione artistica permette di trasformare in qualcosa di comunicabile e condivisibile con gli ascoltatori, chiamati anch’essi a un’inconscia e ulteriore funzione di holding che si accompagna all’immedesimazione e ad aspetti di identificazione; vedremo come, nei casi di rockstar con un sé fragile e traumatizzato, l’arte non sarà sufficiente a curare, se non per un periodo, ferite troppo profonde.
Presento ora alcuni first album che sono considerati vere e proprie pietre miliari: dischi-adolescenze che hanno rappresentato un documento di riconoscimento della carriera successiva, spesso drammaticamente breve, per evidenziare alcuni aspetti che li rendono vere e proprie opere d’arte, che meritano di essere ascoltate con un orecchio psicoanalitico. Proseguendo il filo ‘adolescenziale’, mi soffermerò di volta in volta sulla prima canzone di questi album, perché è un’ouverture in filigrana adolescenziale che presenta il mood, le tematiche, il sound che si svilupperà nel disco. E soprattutto, ci presenta l’artista.
—
[1] Pep Archive sta per Psychoanalytic Electronic Publishing, è il più vasto archivio online di articoli e libri di psicoanalisi.
[2] Nel 2009 Kenneth Wright ha pubblicato il libro Mirroring and Attunement: Self-Realization in Psychoanalysis and Art, nel quale si occupa di psicoanalisi, arte e religione da una prospettiva relazionale, ipotizzando che ognuna di queste attività funga da strumento per il dialogo creativo.
[3] Dopo i primi album di musica folk acustica, pubblicati tra il 1962 e il 1964, contenenti i suoi capolavori contro la guerra (come Blowin’ in the wind e The times they’re a-changin’) Bob Dylan opera quella svolta ‘elettrica’ che gli costerà l’accusa di ‘traditore’ da parte dell’intera scena folk mondiale, ma che gli permetterà di ampliare a dismisura i propri orizzonti musicali, inventando il folk rock, trovando una dimensione artistica in cui poter parlare di sé e dare forma più intima al suo talento poetico, fino a vincere il Nobel per la letteratura nel 2016.
[4] Uno dei primi esempi di questo cambiamento furono i Beatles: dapprima George Harrison si interessò al sitar, strumento indiano derivato dalla lira, e lo suonò in alcuni brani del gruppo; nel 1968 si recarono, poi, tutti e quattro in India, ospiti del guru Maharishi per dedicarsi alla meditazione, e lì composero alcuni brani per il White Album, pubblicato dopo il ritorno in Inghilterra. In un’ottica psicoanalitica credo sia significativo aggiungere come proprio la musica indiana fu la colonna sonora che accompagnò la gravidanza della mamma di George Harrison.
[5] The Who, “My Generation” (1965). [6] The Rolling Stones, “(I can’t get no) Satisfaction” (1965).
[7] Questo il primo verso di My Generation: “People try to put us down (talkin’ ’bout my generation) / Just because we get around (talkin’ ’bout my generation) / Things they do look awful cold (talkin’ ’bout my generation) / I hope I die before I get old (talkin’ ’bout my generation)”
Questi alcuni versi di (I can’t get no) Satisfaction: “When I’m driving in my car / When a man come on the radio / He’s telling me more and more / About some useless information / Supposed to fire my imagination / That’s what I say / I can’t get no satisfaction”.
[8] The Beatles, “Twist and Shout” (1963):
[9] The Beatles, “All you need is love” (1967).
[10] The Beatles, “Julia” (1968).
Questo è un estratto del testo, che rende bene il senso della canzone e del suo essere autobiografica: “When I cannot sing my heart / I can only speak my mind, Julia / Julia, sleeping sand, silent cloud / Touch me so I sing a song of love / Julia”.
[11] Tra i primi nomi che mi vengono in mente: Bono, leader degli U2, la cui mamma morì colpita da aneurisma cerebrale al funerale del nonno, quando il figlio aveva quattordici anni; Lou Reed, a quattordici anni ricoverato in una clinica psichiatrica e sottoposto a varie ‘sedute’ di terapia elettroconvulsiva perché i suoi genitori volevano ‘curare’ la sua bisessualità; e la cantante americana Mary Gauthier, straordinaria artista sconosciuta al grande pubblico, che nella sua autobiografia, Saved by a Song, pubblicata nel 2021, sottolinea come il connubio psicoterapia-musica l’abbia salvata, nonostante una storia di abbandono alla nascita, adozione da parte di una famiglia gravemente problematica e di pesante tossicodipendenza adolescenziale.
[12] Anche il fondatore dei Pink Floyd, Roger Waters, in una recente intervista dedicata all’album The Dark Side of the Moon, pubblicato nel 1973 e ad oggi considerato uno dei capolavori della storia della musica, utilizza questo concetto per descrivere il senso e il significato del brano di apertura dell’opera (intitolato Speak to me / Breathe), spiegando come l’obiettivo fosse quello di condensare in esso temi e sonorità che sarebbero poi stati sviluppati nei brani successivi.
.

Sperimentare: breakdown adolescenziale o esperienza di crescita
“Playing hide and seek with the ghosts of dawn
Waiting for a smile from a sun child”
(Moonchild, King Crimson, 1969)[1]
I primi due dischi che vorrei presentarvi, molto differenti tra loro per il sound e l’ambiente in cui hanno preso vita, sono accomunati dalla spinta a sperimentare dei due leader dei gruppi, Jim Morrison nei Doors e Robert Fripp nei King Crimson. Sperimentare è un termine che utilizzo nell’incontro con i genitori dei pazienti adolescenti, spesso spiazzati e confusi dalle scelte e dai comportamenti dei figli: descrive bene le esperienze del mondo adolescenziale, necessarie per portare avanti un processo di soggettivazione e sviluppo del sé, ma può rappresentare anche il pericoloso superamento di quei limiti necessari a far sì che le esperienze mantengano una connotazione evolutiva e non portino l’individuo in luoghi dominati dalla distruttività e dall’incomunicabilità.
The Doors (1967), il primo album dell’omonimo gruppo, rappresenta una sperimentazione che segnala il fallimento del processo identitario e di soggettivazione, e il bisogno di fuga in un altrove indefinito; è l’ esempio più eclatante di come un artista diventi iconico e riferimento delle masse giovanili in modo così repentino che la persona – Jim Morrison – autore dei testi e cantante, venga dimenticato sullo sfondo, costretto a indossare i panni di un Falso sé ‘rockstar’ sentito come l’unico modo per essere visto e pensato.
Sin dalla copertina percepiamo la sua presenza inquietante: il suo volto aleggia sui compagni di band, tre musicisti che misero il loro talento a disposizione delle urgenze poetiche compositive dell’amico, arrivato alla musica intorno ai vent’anni nel disperato tentativo di ricevere un riconoscimento da parte di un mondo che aveva già respinto le sue aspirazioni cinematografiche; Jim Morrison, ancor prima di fondare il gruppo con il tastierista Ray Manzarek, consumava ingenti quantità di lsd e marijuana, da lui considerate doors utili all’ampliamento delle aree della mente e al superamento dell’opprimente realtà quotidiana. La prima canzone dell’album è una immediata dichiarazione di questo intento, adottata come inno generazionale per il suo invito a ribellarsi:
“You know the day destroys the night
Night divides the day
Tried to run
Tried to hide
Break on through to the other side”[2]
Le radici della canzone si ritrovano nella mente di un giovane che non ha mai trovato una propria side, un luogo in cui potersi collocare e che vede ormai i propri aspetti trasgressivi diventare irrimediabilmente distruttivi.
Figlio di un ufficiale della Marina, Jim Morrison trascorre gli anni dell’infanzia e dell’adolescenza a traslocare frequentemente con i famigliari da una città all’altra degli Stati Uniti, mentre il padre per lunghi periodi è assente; Jim fatica a legare con i coetanei, che vedono in lui un ragazzo originale col quale è sempre difficile raggiungere un’autentica profondità relazionale, condizionata dal suo mettere a disagio gli altri con scherzi pesanti e continue provocazioni[3]. L’adolescenza è un periodo buio per Jim, che cerca in modi sempre troppo originali di ritrovare quell’attenzione e quel riconoscimento che non aveva ricevuto da una madre molto rigida e incapace di accogliere l’individualità del figlio, ragazzo ricco di passioni ma distante dalle aspettative conservatrici dei genitori.
Penso che Break on through non sia tanto l’immagine di un momento di passaggio e crescita ma di un momento di rottura, di un breakdown evolutivo (Moses e M. Egle Laufer, 1984) ormai avvenuto: la voce di Jim è rabbiosa ma disperata, la canzone prosegue incalzante ma alla fine sembra interrompersi all’improvviso, come se tutta l’energia sprigionata finisca in quel gate straight deep and wide[4] di cui parla la canzone, un’immagine dell’abisso in cui stava sprofondando il fragile Jim.
Un disco in cui canzoni piene di energia e pulsionalità si alternano a momenti dall’atmosfera notturna e malinconica – marchio di fabbrica della discografia successiva – fino alla conclusiva The End[5], dieci minuti di musica in cui la distruttività cresce minuto dopo minuto arrivando al richiamo edipico finale, rabbioso e urlato, che qui rappresenta la furia adolescenziale e il rapporto ormai deteriorato e denso di rancore verso i genitori: “Father, I want to kill you / Mother, I want to fuck you!”
Alla fine del 1964, infatti, il padre accetta un trasferimento a Londra, e Jim, allora ventunenne, vede i suoi genitori per l’ultima volta durante il periodo natalizio; pochi mesi dopo matura l’idea di creare un gruppo musicale, cominciando ad annotare pensieri e versi poetici su quaderni che porta sempre con sé. Entusiasta, decide di informare la sua famiglia, scrivendo loro che “tutti si facevano grasse risate per la sua laurea in Cinematografia, così adesso stava in una rockband e cantava” (Hopkins e Sugerman, 1980, 79). Il padre gli risponde con una lettera in cui dichiara la sua ferma contrarietà, ricordandogli che da bambino aveva abbandonato le lezioni di pianoforte e si era sempre rifiutato di unirsi alla famiglia nei canti di Natale, e considera pertanto “una sciocchezza” (ibid.) la scelta del figlio. Dopo aver letto questa lettera, Jim Morrison non scriverà mai più ai suoi genitori e, per alcuni anni, racconterà ai membri del suo gruppo di essere orfano.
Jim Morrison è uno degli esempi più lampanti di come la sofferenza e il genio artistico camminino insieme e di come l’opera d’arte non possa che essere parte e prodotto della vita dell’artista. Questo esordio, come i dischi successivi dei Doors, presentano quel binomio indissolubile “fra il lento incedere della morte che erode i confini della vita e le flebili e sofferte manifestazioni della vita che cerca di guadagnare terreno sulla morte” (Spagnolo e Northoff, 2022, 101); una battaglia che Jim Morrison ha perso a soli 27 anni, tre anni dopo l’uscita di questo disco, un periodo sufficiente a trasformarlo in uno dei grandi miti dell’intera storia del rock.
—
[1] King Crimson, “Moonchild” (1969).
[2] “Tu sai che il giorno distrugge la notte / La notte divide il giorno / Hai provato a correre / Hai provato a nasconderti / Irrompi dall’altra parte”
[3] Attitudini che rimasero prerogativa del Morrison giovane adulto sul palco: i concerti dei Doors saranno sempre caratterizzati dalle performance imprevedibili e provocatorie di Jim, che simulava rapporti sessuali e provocava spesso i numerosi poliziotti presenti, che in alcune occasioni interruppero i concerti e lo arrestarono.
[4] Nel testo: “The gate is straight, deep and wide” (“Il cancello è dritto, profondo e ampio”).

In Inghilterra, l’altro luogo di grande fermento musicale giovanile, in cui il rock incontrava e si fondeva col folk e il blues, nel 1969 esce un’opera prima che destabilizzerà non tanto il mondo adulto ma il mondo giovanile:
In the court of the Crimson king dei King Crimson, il gruppo fondato da Robert Fripp è il risultato di una sperimentazione evolutiva, che sostiene la crescita del soggetto, un transito in adolescenza che permette un ingresso modulato e autentico nel mondo adulto.
Il 1969 è un anno di transizione in cui musica pop e rock si allontanano dalla psichedelia, molti artisti sentono sempre più forte il desiderio di esplorare e progredire, cercando forme musicali che diano – in modo narcisisticamente sano – voce al talento musicale: e In the court of the Crimson king “aveva un sound così nuovo e musicalmente audace che nessuno suscitò altrettanto scalpore né alzò il livello in termini di ambizione” (Barnes, 2020, 61).
Robert Fripp, sin da bambino dedito all’apprendimento della tecnica chitarristica, nel corso della vita astemio e contrario all’uso di sostanze stupefacenti, con questo disco offre una delle dimostrazioni musicalmente più riuscite di come un sé coeso e un’ideale dell’Io integrato possano esprimersi coraggiosamente rispetto ai tempi, costruendo fondamenta solidissime che non abbandonerà più nel corso della carriera, circondandosi nei decenni successivi di musicisti dediti, come lui, all’arte.
In questa opera penso si possa concretamente vedere cosa intende Musella parlando di rappresentazione e individuazione dell’ideale dell’Io, considerato “una formazione più matura e organizzata, derivata dal narcisismo secondario” (Musella, 2023): un disco in cui gli aspetti narcisistici di vita (Green, 1983) sostengono una sperimentazione coraggiosa, originale e autentica.
Robert Fripp, questo album e tutto il progressive rock di quegli anni furono, a mio parere, una risposta, una sfida identitaria a tutti coloro che suonavano rock tradizionale, proponendo una musica nuova, che poteva contenere anche richiami a quella classica e al jazz.
Un episodio rappresenta tutto questo: poche settimane prima della pubblicazione del disco, i King Crimson furono invitati a suonare al concerto organizzato dai Rolling Stones a Hyde Park per commemorare Brian Jones, il loro chitarrista morto pochi giorni prima; di fronte a cinquecentomila persone in attesa degli Stones e del loro nuovo chitarrista di estrazione blues, Mick Taylor, i King Crimson “invece di suonare della roba rilassante che accarezzasse il cappelluto pubblico, o magari dello scatenato blues rock su cui muoversi a ritmo, esordirono con la densa aggressività di 21st century schizoid man […] qualcosa di mai sentito prima” (Barnes, 2020, 64).
Tutto il disco è un adolescente nuovo e sconosciuto a molti giovani fans del rock, misterioso e difficile da comprendere con i suoi cinque brani di durata superiore ai sei minuti, ma affascinante e onirico. Proprio come a Hyde Park, 21st century schizoid man[1] apre l’album con una furia perturbante, la sensazione è quella di essere in un’atmosfera caotica in cui tutto è destrutturato e in disordine:
“Cat’s foot, iron claw
Neurosurgeons scream for more
Paranoia’s poison door
21st century schizoid man”[2]
Un testo che prosegue con altre immagini originali e un po’ strambe, e la voce di Fripp che canta in modo distorto sembrano non lasciare spazio a un ascolto coerente e immedesimato: ma col passare dei minuti l’ascoltatore ritrova un filo conduttore che guida la canzone, ci si rende conto che a ogni momento di destrutturazione segue un momento in cui gli strumenti si ritrovano e corrono insieme; improvvisamente abbiamo la sensazione che il brano abbia un senso, i pezzi vengono riordinati e formano un mirabile tutt’uno.
21st Schizoid man è, a mio parere, una straordinaria descrizione in musica del caos evolutivo dell’adolescenza: un processo lungo fatto di dissonanze e sintonizzazioni, scatti improvvisi e rallentamenti, momenti in cui ogni pezzo-strumento del sé-canzone sembra allontanarsi e andare alla deriva, per ritrovare poco dopo un recupero e un’unità. Tutto il disco rispecchia questo alternarsi di momenti al limite del silenzio a improvvise sonorità ruvide: un marchio indelebile dell’intera carriera di Fripp, con il suo gruppo ma anche in altri progetti musicali.
—
[1] King Crimson, “21st schizoid man” (1967).
[2] “Piede di gatto, artiglio di ferro / I neurochirurghi urlano per avere di più / La porta avvelenata della paranoia / L’uomo schizoide del 21° secolo”.

Il Vero sé in azione
“Il rock ‘n’ roll è la mia arte”
(Patti Smith)
Scelgo per questo paragrafo il titolo dell’edizione italiana del bellissimo libro di Margaret Little (1990)[1] dedicato alla sua analisi con Winnicott perché ben rappresenta la genesi delle opere prime di due rockstar americane, le cui vicende si addicono a un commento che l’analista inglese fece alla Little: a seguito del racconto di un episodio di autoaffermazione in cui aveva, per la prima volta, inveito contro sua madre, Winnicott disse: “Lei doveva questo a se stessa da molto tempo” (Little, 1990, 56).
Parole che valgono anche per il lungo percorso di formazione che porta Bruce Springsteen e Patti Smith al loro esordio discografico: due rockstar accomunate dal desiderio di farsi spazio ed essere riconosciute per il loro valore artistico, capaci di mantenersi autentiche e arrivare dopo molti anni di apprendistato al primo album.
Greetings from Asbury Park N.J è il disco d’esordio di Bruce Springsteen, pubblicato nel 1973: dopo anni di gavetta trascorsi a suonare con la sua band ovunque ci fosse un palco, abitando spesso in sistemazioni precarie, scegliendo di non seguire la famiglia che si era trasferita in California per restare nel New Jersey e coltivare i propri sogni di rock ‘n’ roll, arriva per il Boss – questo il suo soprannome – la grande occasione, e c’è in esso tutta la spinta entusiasta di un adolescente.
Una pulsione rock nata molti anni prima vedendo Elvis Presley con la sua chitarra in televisione, sentendo che quella poteva essere “la risposta alla mia dolorosa alienazione, una ragione di vita, un motivo per entrare in contatto con gli altri sfigati come me” perché “Io volevo… io avevo bisogno… di rock! Subito!” (Springsteen, 2016, 55).
E Greetings from Asbury Park, N.J. è il punto d’arrivo di questo entusiasmo di ragazzo di periferia che non aveva trovato una propria identità, in un ambiente famigliare soffocato dalla depressione e dalla dipendenza dall’alcol del padre, fino all’incontro con la musica: grazie a questa passione Bruce Springsteen inizierà anche a scrivere testi, come quelli presenti in questo album, che hanno quasi tutti radici autobiografiche: “nascevano da persone, luoghi, locali, esperienze ed episodi che conoscevo e avevo vissuto in prima persona” (Springsteen, 2016, 194).
Tutta l’energia che caratterizzerà l’intera carriera di Springsteen, fatta di lunghi tour e concerti che sono vere e proprie maratone sul palco, è qui presente a partire dall’ incipit della prima canzone, Blinded by the light[2], parole quasi incomprensibili e senza senso, se non quello di citare subito la gioventù:
“Madman drummers bummers and Indians
in the summer with a teenage diplomat.
In the dumps with the mumps
as the adolescent pumps his way into his hat.”[3]
Il disco prosegue con la commovente Growin’ Up[4], che Bruce Springsteen nei concerti di quegli anni presentava al pubblico come un brano sulla crescita, sul diventare uomo: la giovane rockstar del New Jersey a cinquant’anni di distanza è ancora capace di pubblicare album e offrire ai propri fans performance live appassionanti e coinvolgenti come allora.
—
[1] Il titolo originale dell’opera è, curiosamente, Psychotic anxieties and containment: titolo che si addice perfettamente ad altri artisti citati in questo scritto, come Jim Morrison e Kurt Cobain.
[2] Bruce Springsteen, “Blinded by the light” (1973).
[3] “Batteristi pazzi, delinquenti e indiani / in estate con un diplomatico adolescente. / Nella discarica con gli orecchioni / mentre l’adolescente si infila il cappello.”
[4] Bruce Springsteen, “Growin’ up” (1973).

Passano solo due anni prima che Patti Smith, da tempo conosciuta a New York come poetessa, pubblichi il suo primo album: Horses.
Da qualche anno aveva iniziato a recitare le sue poesie in pubblico accompagnata dal fido Lenny Kaye alla chitarra elettrica: la poesia diventa canto, parole e corpo sono sempre la matrice della sua arte, stravolgendo, sin da questo primo album la forma canzone strofa-ritornello.
Horses è un disco che sin dalla copertina abbatte le frontiere di genere: Patti non accetta di rappresentare il genere femminile che si aspetterebbe la società, rifiuta anche i ritocchi per cancellare i peli visibili sopra le labbra, vuole essere una persona giovane libera di esprimersi, a proprio agio in una zona fluida tra il femminile e il maschile. Dirà nelle interviste dell’epoca che non era interessata a rivolgersi al mondo intero ma le bastavano cento persone come lei, diverse dagli altri sin da piccole. Tutto questo viene immediatamente etichettato come punk, Patti viene riconosciuta come una delle prime straordinarie performer di questo nascente movimento, ma combatterà sempre per riportare lo sguardo dei fans su di lei come soggetto e sul valore intimo del suo lavoro; al punto che, giunta all’apice del successo con la pubblicazione del singolo Because the Night[1], si ritirò improvvisamente dalla vita pubblica e dai concerti[2].
La prima canzone di Horses è un biglietto da visita che rappresenta perfettamente l’intreccio degli spazi temporali che prende vita nell’arte, in questo caso attraverso l’unione di poesia (passato) e rock (presente) che è la matrice della carriera (futuro) di Patti Smith: Gloria[3] è, infatti, la cover[4] di una hit dei Them, scritta dal loro leader Van Morrison e uscita nel 1964, ma Patti la introduce con una sua poesia intitolata Oath, scritta anni prima come “dichiarazione d’esistenza, quasi si trattasse del giuramento di assumermi la responsabilità delle mie azioni” (Smith, 2010, 264):
“Jesus died for somebody’s sins but not mine.
Meltin’ in a pot of thieves,
Wild card up my sleeve.
Thick heart of stone.
My sins, my own,
They belong to me. Me.”[5]
Una poesia che richiama la scelta dolorosa, quando era ventenne, di dare in adozione la figlia nata da una relazione occasionale: un’esperienza traumatica che la costrinse, durante la gravidanza, ad abbandonare il college e restare a casa per mesi mentre i vicini trattavano lei e i genitori come dei criminali, subendo poi l’odio sadico delle infermiere che la consideravano una peccatrice e la insultavano durante il travaglio. Ed è come se con questa poesia d’esordio Patti Smith decida – lei figlia di testimoni di Geova – come affrontare ed elaborare il suo peccato: attraverso la musica rock.
Gloria è una cover che raccoglie in sé tutta la forza e la rabbia di Patti Smith, e Horses è un album tributo al rock ‘n’ roll, a cui la cantante è grata per avergli “fatto superare un’adolescenza difficoltosa” (ibid., 266) lastricando il percorso di un’intera carriera in cui poesia e musica si fondono per dare vita a uno stile autentico e originale.
—
[1] Patti Smith, “Because the night” (1978).
La canzone era stata scritta da Bruce Springsteen che, quando decise di non inserirla nell’album The darkness on the edge of town, la prestò a Patti Smith, che stava lavorando all’album Easter nello studio di registrazione vicino.
[2] L’ultimo concerto di Patti Smith fu a Firenze, il 10 settembre 1979: già al pomeriggio, appassionata d’arte e in giro per la città, Patti Smith fu costretta a rientrare in albergo per sfuggire ai fans che l’avevano riconosciuta; quando arriva allo stadio per il concerto vede molti agenti in tenuta antisommossa preoccupati di possibili contestazioni. Il concerto andrà bene ma tornando in albergo Patti Smith deciderà di ritirarsi dalla vita da rockstar: tornerà dopo nove anni di silenzio.
[3] Patti Smith, “Gloria” (1975).
[4] Con questo termine si definiscono le nuove versioni, a opera di altri artisti, di canzoni pubblicate in precedenza: possono essere versioni simili all’originale o anche molto diverse. Tra gli esempi più famosi: la cover dei Guns ‘n’ Roses di Knockin’ on Heaven’s Door di Bob Dylan, e le due diverse cover, a opera di Eric Clapton e Sting, della bellissima Little Wing di Jimi Hendrix.
[5] “Gesù è morto per i peccati di qualcuno ma non per i miei. / Sciogliendosi in un vaso di ladri /Il jolly nella mia manica. Cuore spesso di pietra. / I miei peccati, i miei / Appartengono a me. Solo a me.”

Rock e brandelli di sé
“I hurt myself today to see if I still feel
I focus on the pain, the only thing that’s real
(Hurt, Nine Inch Nails, 1994)[1]
Faccio ora un salto in avanti di una quindicina d’anni, per parlare di due opere prime di gruppi che hanno fatto la storia degli anni Novanta, i Nirvana e i Cranberries, e dei loro leader, Kurt Cobain, morto suicida a ventisette anni, e Dolores O’Riordan, annegata a quarantasette anni in una vasca piena d’acqua, sola e ubriaca in una stanza d’albergo londinese.
Sono anni di grande fermento musicale: la nascita del grunge offre una nuova via identitaria al rock e, al contempo, molte cantanti si affermano grazie alla loro voce e alla loro capacità compositive; Kurt Cobain e Dolores O’Riordan sono i massimi esponenti di questi due fenomeni del mondo rock.
Nella loro storia di vita l’arte è un tentativo di prendersi cura di sé, di cercare in essa e nell’ascolto offerto dai fans un vello d’oro che possa alleviare il dolore causato dalle ferite traumatiche.
Bleach, il disco d’esordio dei Nirvana, raccoglie nella sequenza dei brani lo spirito degli adolescenti di quegli anni, attraverso quella distruttività e quella rabbia che sono l’essenza del grunge; ma la passione e il coinvolgimento che Cobain mette in ogni brano è il tentativo di “ricucire i brandelli di un sé” (Spagnolo e Northoff, 2022, 96) fragile che non reggerà il peso della vita e la pressione futura dello show business.
Un giro di basso oscuro e claustrofobico apre l’album e Blew[2], una canzone abrasiva dove il sofferto cantato di Cobain, magistralmente supportato da un sound cupo e distorto, offre un’immediata risonanza musicale-affettiva del giovane cantante e dei suoi dolori, radicati nella traumatica separazione dei genitori e in un’adolescenza caratterizzata dallo sviluppo di gravi e persistenti dolori di stomaco – di probabile origine psicosomatica – e abuso di sostanze, in una realtà di provincia che generava il senso claustrofobico che pervade non solo questa canzone ma tutta la breve discografia dei Nirvana:
“Now if you wouldn’t mind, I would like it blew
And if you wouldn’t mind, I would like to lose
And if you wouldn’t care, I would like to leave
And if you wouldn’t mind, I would like to breathe”[3]
Kurt Cobain e tutto il movimento grunge esprimono il senso di disillusione, cinismo e rabbia della cosiddetta generazione X, quella dei figli dei figli dei fiori ma, a mio parere, questo non è sufficiente a spiegare la forza espressiva della loro musica, a partire da Bleach, un disco che è il tentativo di prendersi cura di sé attraverso l’arte, recuperando “qualche elemento traumatico in modo da poterlo assimilare in una struttura rappresentazionale e simbolica più evoluta. Ma se la struttura del sé è sfilacciata dalle troppe discontinuità vissute nel corso dell’esistenza, questo movimento di recupero fallisce continuamente” (Spagnolo e Northoff, 2022, 100).
Assimilare il trauma in una rappresentazione: questo è stato il tentativo di artisti come Jim Morrison e Kurt Cobain e di molte altre rockstar morte troppo presto o all’apice del successo[4], troppo fragili come personalità per poter elaborare i traumi attraverso il solo processo di rappresentazione. Cobain utilizzò nel corso degli anni dell’adolescenza la scrittura e il disegno nel tentativo di contenere e dare una forma al suo malessere: in questi diari, scannerizzati e pubblicati nel 2003, caratterizzati da una modalità stream of consciousness – come si può vedere nell’immagine riportata qui sotto – si trovano anche le prime bozze dei testi di alcune canzoni che verranno messe in musica e pubblicate in seguito: la musica rock, con la compresenza di più forme d’arte (scrittura, musica, canto), viene pensata come uno spazio transizionale più resistente del semplice diario; come uno spazio multidimensionale in cui offrire una forma elaborativa più profonda alla sofferenza.
Nella sua lettera d’addio Kurt scriverà che era dall’età di sette anni che provava odio verso tutti gli umani[5]: a quel periodo risale la separazione dei suoi genitori, vissuta con profonda vergogna e intensa rabbia dal figlio; perché Kurt Cobain “non era una rockstar, era un ragazzo che contro la sua volontà era diventato un simbolo” (Vites, 2022, 85), tentando di trovare quel contenimento affettivo, vissuto e poi perduto in infanzia, attraverso la sua opera creativa.
___
[1] Nine Inch Nails, “Hurt” (1994).
[3] “Ora, se non ti dispiace, vorrei che svanisse / E se non ti dispiace, vorrei perdere / E se non ti interessa, vorrei andarmene / E se non ti dispiace, vorrei respirare”.
[4] Tra i tanti: Jimi Hendrix, Janis Joplin, Bon Scott (AcDc), Keith Moon (The Who), Amy Winehouse, Syd Viciuos (Sex Pistols), Ian Curtis (Joy Division), Layne Staley (Alice in chains).
[5] “Mi è andata bene, molto bene, e ne sono grato, ma da quando ho sette anni, sono diventato pieno di odio verso l’umanità in generale. Solo perché sembra così facile per la gente andare d’accordo. Solo perché amo e mi dispiace troppo per le persone probabilmente. Grazie a tutti dal profondo del mio bruciante nauseato stomaco per le vostre lettere e la preoccupazione negli anni passati. Sono un bambino troppo incostante e lunatico!” (Brano tratto dalla lettera d’addio di Kurt Cobain)
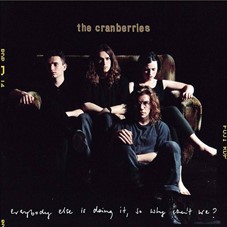
Il primo disco dei Cranberries, Everybody else is doing it, so why can’t we?, uscito quattro anni dopo Bleach, è il primo incontro con la meravigliosa voce di Dolores O’Riordan, che la rivista musicale inglese Melody Maker definì la voce di una santa intrappolata in un’arpa di vetro.
Sin dalla copertina, in cui si presenta pallida e molto magra, con lo sguardo basso, la cantante sembra volersi nascondere: dirà più volte nelle interviste che avrebbe voluto cantare senza essere mai guardata, riconoscendo di provare disagio e vergogna, emozioni probabilmente riconducibili agli abusi sessuali subiti tra gli otto e i dodici da un amico di famiglia[1]. Un’esperienza traumatica che verrà pubblicamente raccontata dalla stessa Dolores nel 2013 in un’intervista alla rivista Life Magazine in cui spiegherà come le conseguenze di quelle violenze furono le “malattie che ho iniziato a sviluppare all’inizio dell’età adulta, come il mio disturbo alimentare, la depressione e i crolli” (Vites, 2022, 124). Un’esperienza che la segnò nel corpo e nell’anima, che ha permesso agli ascoltatori di scoprire una voce da mezzosoprano che sembra spesso un lamento, e che sin da questo primo album ammanta l’atmosfera, con i musicisti che la sostengono come a riconoscere i suoi bisogni interni e l’urgenza di trovare un modo per esprimerli. La prima canzone dell’album, I still do[2], si riferisce forse a una relazione sentimentale nella quale Dolores non sa come muoversi:
I’m not ready for this
Though, I thought I could see
I don’t want to leave you, even though I have to
I don’t want to love you, oh, I still do”[3]
Credo sia, in termini più generali, una testimonianza del suo difficile rapporto con la vita, le relazioni e il corpo: il trauma dell’abuso prende la forma dell’ambivalenza, dell’impossibilità di trovare un senso coerente all’esistenza; immagino che la canzone possa rappresentare anche il mancato riconoscimento del trauma da parte dell’ambiente, per cui Dolores sembra prigioniera di sentimenti difficili da integrare riguardo ai suoi famigliari, che non l’hanno protetta. L’atmosfera musicale e il timbro di voce della O’Riordan fanno di I still do un opening commovente, simbolo creativo della sua tragica vita, e marchio di fabbrica dei suoi dischi successivi, con i Cranberries e da solista.
In questo transito dalla copertina alla prima canzone ritroviamo tutta quella sofferenza che “sta all’opera d’arte come il dolore alla postura del corpo” (Spagnolo e Northoff, 2022, 102): perché il rock è un’arte che costringe a mettere in gioco non solo la mente e il suo prodotto creativo ma anche il corpo, visto e desiderato nelle fantasie di milioni di persone. Nelle copertine degli album successivi il posto, e la postura, di Dolores O’Riordan continueranno a parlare del suo corpo, del suo disturbo alimentare anoressico e della sua sofferenza, in alcuni periodi contenuta ed espressa ma in altri debordante e artisticamente muta[4].
Blew e I Still do sono due canzoni molto simili nella struttura compositiva: entrambe rappresentano un dialogo tra ciò che dovrebbe essere e ciò che è, come se entrambi gli artisti volessero, sin dal passo d’esordio, presentare il loro dramma esistenziale, il peso dei traumi sofferti e l’effetto che hanno su di loro: un sé incompleto, difficile da tenere insieme, pieno di dubbi e sbalzi d’umore, di cui entrambi soffriranno.
Conclusioni
“Il fatto che Donald conoscesse la musica e l’amasse tanto era una gioia per entrambi […]
Gli piaceva molto anche la musica dei Beatles e comprò tutti i loro dischi”
(Clare Winnicott)
Un filo lega la citazione freudiana all’inizio di questo lavoro[5] con le parole della moglie di Winnicott: Freud – e tutta la prima psicoanalisi – non avrebbe mai potuto conoscere la musica rock, per ovvie ragioni cronologiche e non solo per la decisione di escludere il sonoro-musicale dalla disciplina che stava costruendo; Donald Winnicott che ascolta i vinili dei Beatles (e penso in particolare al White Album) è un’immagine di buon auspicio per un futuro dialogo tra la nostra disciplina e questa giovane forma d’arte.
Inoltre, il concetto winnicottiano di holding è una delle parole fondamentali per la costruzione di un dizionario rock – psicoanalisi ed esprime la funzione che questa ‘terza via’, autobiografica e rivolta alle aree traumatiche, della musica rock riveste per l’autore: l’ipotesi che ho presentato è che – anche per la rockstar – “nel processo di creazione della sua opera d’arte, l’artista crei un holding structure, che sostiene il suo sé affettivo” (Wright, 2022, 351).
L’opera d’arte tenta di contenere l’esperienza affettiva e relazionale dell’artista, spesso segnata da esperienze traumatiche: ri-creandola (Wright, 2022) in una nuova forma transunziente[6] (Bollas, 1999) che funge da “scrigno in cui l’esperienza possa essere custodita” (Wright, 2022, 356), potendo fungere da ulteriore ambiente facilitante (Winnicott, 1974) che non può, comunque, essere considerato sostitutivo di ciò che è mancato nell’esperienza precoce.
Nella storia del rock, a partire dalla metà degli anni Sessanta, l’opera musicale diventa una forma d’arte proprio per il modo in cui molti artisti utilizzano la loro esperienza creativa. Un’esperienza che, provando a collocarla metaforicamente nello studio dell’analista, non vede più – come in quella seconda fase che ho definito fase ‘manifesto’ – il cantante-terapeuta impegnato a mettere in parole le emozioni del paziente-ascoltatore; adesso è il paziente-rockstar che chiede al terapeuta-ascoltatore un lavoro “di ospitalità emotiva” (Nicoli, 2023, 73) per qualcosa che prima “non ha mai trovato rappresentazione” (ibid.); quando Joni Mitchell afferma che i suoi dischi sono stati sempre molto soggettivi ma, lei spera, anche universali, descrive quel processo di immedesimazione, sintonizzazione emotiva e ascolto fluttuante che fa sì che “la creazione artistica oggettivizza la soggettività (dell’artista), rendendola più visibile e reale” (Wright, 2022, 358), attraverso una condivisione che non è soltanto più listen to ma diventa to feel. È così che all’holding structure (Wright, 2022) che caratterizza l’opera d’arte in sé si aggiunge l’holding affettivo dell’ascoltatore, esito di un disco che è soggettivo e universale allo stesso tempo: l’ascoltatore può ritrovare, attraverso l’opera d’arte, un contatto con il proprio sé e le proprie fragilità.
E tutto questo inizia con il disco d’esordio, l’adolescenza della rockstar: un concentrato di esperienze, esigenze, aspettative, progettualità che irrompe sulla scena alla stregua di questo periodo nella vita di ognuno e che crea le solide fondamenta emotive del rapporto tra la rockstar e il suo pubblico. Il disco d’esordio è un agente organizzante (Cahn, 1998), un caposaldo della soggettivazione, l’inizio di un processo di individuazione, una fase cruciale della formazione del sé rock: questi concetti, utilizzati da tempo in psicoanalisi per definire l’adolescenza, si addicono a descriverlo e, come può accadere nell’esperienza delle persone giovani, questi processi possono fallire nel loro obiettivo di accompagnare l’artista alla carriera adulta, perché le opere d’arte sono contenitori non sufficienti – se lasciati da soli – ad assorbire l’impatto della lunga onda della catastrofe (Borgogno, 1999).
Concludo con una grande rockstar che ha attraversato tutto il periodo rock da me analizzato, Neil Young: l’hippie solitario[7] che è stato uno dei grandi protagonisti della scena musicale della West Coast di fine anni Sessanta, prima nei Buffalo Springfield poi da solo e, per un breve ma leggendario periodo, con Crosby, Stills e Nash; transitato faticosamente negli anni Settanta, a causa della perdita di due cari amici per overdose e della nascita di un figlio con gravi problemi neurologici; un chitarrista insignito poi del titolo di ‘padre del grunge’ per il suo sound elettrico.
—
[1] Esperienza traumatica che prese anche la forma di una toccante canzone dal titolo Fee Fi Fo, corrispondente inglese dell’italiano ‘Ucci Ucci’ che l’orco esclama nelle favole, contenuta nel quarto album della band, Bury the hatchet (1999).
The Cranberries, “Fee Fi Fo” (1999).
[2] The Cranberries, “I still do” (1993).
[3] “Non sono pronta per questo / Tuttavia, pensavo che lo sarei stata
Non riesco a vedere il futuro / Tuttavia, pensavo di poterlo vedere
Non voglio lasciarti / Anche se devo
Non voglio amarti / Oh, continuo a farlo.”
[4] Nel 1997 i Cranberries furono costretti a interrompere il tour mondiale seguito alla pubblicazione del loro terzo album, To the faithful departed, a causa del grave stato depressivo in cui era caduta Dolores; crollo da lei stessa in seguito descritto come un periodo in cui era anoressica, non mangiava e viveva con una tazza di caffè e una sigaretta sempre in mano.
[5] “Su noi profani ha sempre esercitato una straordinaria attrazione il problema di sapere donde quella personalità ben strana che è il poeta tragga la propria materia” (Freud, 1907, 375)
[6] Bollas (1999, 217) sostiene che l’arte (in particolare la musica, la pittura e la scrittura) abbia il potere di trasferire la realtà psichica in un altro ambito, come nella transustanziazione. Bollas intende dunque l’opera d’arte come un oggetto transunziente in quanto non si limita semplicemente ad esprimere il Sé ma lo ri-forma.
[7] The Loner (Il solitario) è stato il primo grande successo di Neil Young, pubblicato nel 1968 nel suo disco d’esordio solista, probabilmente autobiografico sin dal titolo. Il sogno di un hippie è il titolo della sua autobiografia, pubblicata in Italia nel 2013.
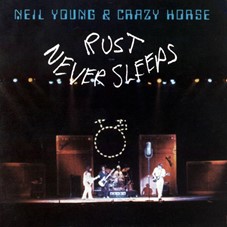
Nel 1979, Neil Young pubblicò l’album Rust Never Sleeps che era un manifesto delle sue due anime musicali: un primo lato completamente acustico e rilassato e un secondo lato elettrico e distorto; il disco comincia con My My, Hey Hey[1], una breve ballata acustica di sola chitarra e armonica in cui Neil, nella prima strofa, canta:
“My My, Hey Hey / Rock and roll is here to stay
It’s better to burn out than fade away”
“E’ meglio bruciare in fretta che svanire lentamente”: parole che Kurt Cobain citò nella lettera scritta prima di suicidarsi con un colpo di fucile nella sua casa di Seattle nel 1994, tragedia che gettò nello sconforto Neil Young, che nei giorni precedenti aveva cercato senza successo di mettersi in contatto con lui, preoccupato per le sue condizioni[2].
Rust never sleeps si conclude con la stessa canzone, suonata in una dirompente versione elettrica: Neil modifica il titolo, che diventa Hey Hey, My My[3] e sostituisce le parole citate con le seguenti:
“Hey Hey, My My / Rock and roll will never die
There’s more to the picture than meets the eye”
“Nel quadro c’è di più di quello che salta all’occhio”, parafrasando: nella canzone c’è di più di quello che salta all’orecchio, e nel rock c’è molto di più di quello che vediamo e ascoltiamo.
—-
[1] Neil Young, “My my, hey hey” (1979).
[2] La lettera di Kurt Cobain si concludeva così: “Non ho più passione, perciò ricordate, è meglio bruciare in fretta che svanire lentamente. Pace, amore, empatia”.
[3] Neil Young, “Hey hey, my my” (1979).
Bibliografia
Barnes M. (2020). Storia del progressive rock. Bologna, Odoya, 2021.
Bollas C. (1999). Il mistero delle cose. Milano, Raffaello Cortina, 2001.
Borgogno F. (1999). La «lunga onda» della catastrofe e le «condizioni» del cambiamento psichico nel pensiero clinico di Ferenczi. In Bonomi C. e Borgogno F. (a cura di), La catastrofe e i suoi simboli, Torino, Utet, 2001.
Chasseguet Smirgel J. (1975). L’ideale dell’Io. Milano, Raffaello Cortina, 1991.
Carnevali C. (2015). L’ascolto della musica rock come disposizione a cogliere l’inconscio. In De Mari M., Carnevali C., Saponi S. (a cura di), Tra psicoanalisi e musica, Roma, Alpes.
Freud S. (1907). Il poeta e la fantasia. O.S.F., 5.
Freud S. (1914). Il Mosé di Michelangelo. O.S.F., 7.
Giaconia G. (1997). Adolescenza: mutamenti e patologia. In Semi A. A. (a cura di), Trattato di psicoanalisi, Milano, Cortina.
Green A. (1983). Narcisismo di vita Narcisismo di morte. Roma, Borla, 2005.
Hopkins J., Sugerman D. (1980). Nessuno uscirà vivo di qui. Bologna, Kaos Edizioni, 1990.
Kestemberg E. (1980). Notule sur la crise de l’adolescence. De la déception à la conquête. Revue Française de Psychanalyse, 44: 523-530.
Laufer M., Laufer M. Eglé (1984). Adolescenza e breakdown evolutivo. Torino, Bollati Boringhieri, 1986.
Little M. (1990). Il vero sé in azione. Roma, Astrolabio, 1993.
Musella R. (2023). Ideale dell’Io. A cura di R. Musella, SPIWEB
Smith P. (2010). Just kids. Milano, Feltrinelli.
Spagnolo R. (2017). An unexpected pathway for interpsychic exchange: Music in the analysis of young adult. In B. N. Seitler & K. S. Kleinman, Essays from cradle to couch, Astoria, IP Books, 2017.
Spagnolo R., Northoff G. (2022). Il sé dinamico in azione. Milano, Franco Angeli.
Springsteen B. (2016). Born to run. Milano, Mondadori.
Trabucco L. (2007). 1899: esplorazioni dell’inconscio tra psicoanalisi e arte. Riv. Psicoanal., 53, 673-696.
Vites P. (2022). Rock ‘n’ roll suicide. Bologna, Caissa.
Winnicott C. (1989). Donald W. Winnicott: una riflessione. In Winnicott D. W., Esplorazioni psicoanalitiche, Milano, Raffaello Cortina, 1995.
Winnicott D. W. (1974). La paura del crollo. In Winnicott D. W., Esplorazioni psicoanalitiche, Milano, Raffaello Cortina, 1995.
Wright K. (2009). Mirroring and Attunement: Self-Realization in Psychoanalysis and Art. Londra, Routledge.
Wright K. (2022). Verso una teoria dell’holding. La prospettiva dalla creazione artistica. Richard e Piggle, 30, 351 – 362.
Vittorio Gonella, Cuneo
Società Italiana di Psicoanalisi e Psicoterapia – Sándor Ferenczi
*Per citare questo articolo:
Gonella V., (2024
) “Break on through (to the other side). Il disco d’esordio: processo di soggettivazione di una rockstar”, Rivista KnotGarden 2024/1, Centro Veneto di Psicoanalisi, p. 148-180
Per una lettura più agile e per ulteriori riferimenti di pagina si consiglia di scaricare la Rivista in formato PDF.
Condividi questa pagina:
Centro Veneto di Psicoanalisi
Vicolo dei Conti 14
35122 Padova
Tel. 049 659711
P.I. 03323130280