Sezione Locale della Società Psicoanalitica Italiana
Sezione Locale della Società Psicoanalitica Italiana
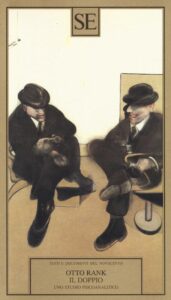
Presentato da Marta Oliva
Autore: Otto Rank
Titolo: “ Il doppio. Uno studio psicoanalitico “
Editore: SE, Studio Editoriale, 2001
Collana: Testi e documenti del Novecento
Anno prima pubblicazione in lingua originale: 1914
Numero pagine: 118
Quarta di copertina:
Il tema del doppio, che Rank trasforma qui nel punto di partenza per l’indagine psicoanalitica, è un chiaro paradosso. Per alcuni aspetti sembra paradigmatico dell’esperienza umana, inciso nelle sue radici, universalmente presente da tempi immemorabili. Per altri aspetti è chiaro che va inquadrato storicamente, perché la sua popolarità e la sua fulminea diffusione risalgono al periodo romantico. Dopo aver introdotto il tema prendendo a modello un noto film dell’epoca, Lo studente di Praga, Rank concentra la sua analisi sulla straordinaria quantità di materiale offerta e tenta innanzitutto di redigerne un catalogo, seppur provvisorio. I numerosi esempi vanno da Hoffman, Chamisso, Andersen, Lenau, Goethe, Jean Paul, Heine, de Musset, Maupassant, Wilde, Kipling ai più famosi “William Wilson” di Poe e “Goliadkin” di Dostoevskij. All’inizio il XIX secolo questo tema è onnipresente e getta la sua ombra e la sua eco ben oltre la fine del secolo. RanK si dedica poi al materiale antropologico e redige un catalogo ugualmente meticoloso tratto dalle forme di superstizione, dai riti e dei tabù dei popoli primitivi, tutti fondati sull’idea del doppio […]. Le storie incentrate sul doppio hanno tutte alcune caratteristiche strutturali comuni, possono però approdare a esiti diversi. Il soggetto, sempre maschile, si confronta col suo doppio, l’immagine di se stesso; questo confronto può condurre alla sparizione dell’immagine riflessa o dell’ombra oppure a un patto; l’immediata conseguenza è una terribile angoscia, la dissoluzione della realtà del soggetto, la distruzione delle fondamenta del suo mondo. Solitamente, solo il soggetto può vedere il proprio doppio che gli appare esclusivamente in privato, oppure solo lui può percepirne la presenza. Inoltre il doppio produce due effetti apparentemente contraddittori. Da una parte opera ai danni del soggetto, gli appare nei momenti meno opportuni, lo condanna al fallimento. Dall’altra realizza i suoi desideri più reconditi o rimossi, agisce come il soggetto non oserebbe mai, o come la sua coscienza non gli permetterebbe mai di agire. Se il finale è tragico, il soggetto uccide il proprio doppio ma, uccidendolo, uccide se stesso, non sapendo che la sua reale sostanza e il suo più autentico essere si concentrano in lui. “Tu hai vinto e io soccombo“ dice il doppio di Wilson nel racconto di Poe “ma da questo momento anche tu sei morto, morto per il mondo, per il cielo per la speranza! Tu vivevi in me, e ora che io muoio, puoi vedere in me la tua immagine: uccidendomi ti sei ucciso”. (Dallo scritto di Mladen Dolar)
Biografia dell’autore:
Otto Rank (1844) nasce a Vienna da una famiglia di origine ebraica di bassa estrazione economica e culturale. È stato il primo non laureato in Medicina a diventare psicoanalista. Si è laureato in filosofia nel 1912 dopo aver incontrato Freud nel 1906. Rank inizia a scrivere testi psicoanalitici nel 1907 nei quali comincia a coniugare il mondo dell’arte con i concetti psicoanalitici postulati da Freud. Otto RanK, appassionato lettore, ha utilizzato le sue conoscenze in ambito letterario, artistico e mitologico per avanzare delle ipotesi psicoanalitiche. Ha cominciato la sua attività di analista al termine della prima guerra mondiale, dopo avere ricevuto l’approvazione da parte di Freud. Il rapporto tra Rank e Freud è stato inizialmente molto stretto; Rank era uno degli allievi preferiti di Freud. A partire dal 1920, però, Rank ha cominciato ad allontanarsi dalla psicoanalisi ortodossa e il rapporto con Freud e con gli altri analisti dell’epoca si è notevolmente modificato e raffreddato. In seguito all’inasprirsi dei rapporti con i colleghi viennesi si è trasferito con la moglie a Parigi per poi scegliere di lavorare negli Stati Uniti per qualche anno, rientrare a Vienna e trasferirsi nuovamente negli Stati Uniti. E’ morto nel 1939, un mese dopo la morte di Freud.
Commento:
L’analisi del film “Lo studente di Praga” è l’elemento che Rank sceglie per introdurre e analizzare il tema del doppio. “Lo studente di Praga” è un film muto del 1913 nel quale Balduin, uno studente sempre al verde e con un forte disgusto per la sua vita, si imbatte nello “strano avventuriero di nome Scapinelli (p.12)” che per aiutarlo, apparentemente, a migliorare la sua condizione di vita gli offre molti soldi in cambio della sua immagine riflessa. Balduin accetta immediatamente tanto è forte il desiderio di una vita diversa e di poter conquistare la contessa Scwarzenberg a cui aveva salvato la vita nel bosco e di cui si era subito innamorato. C’è la vergogna per la vita condotta in precedenza, rappresentata anche dalla figura di Liduska, donna rifiutata non appena Balduin conosce la contessa. L’ombra di Balduin, il suo riflesso, si manifesta sempre quando sta per accadere qualcosa che lo porterebbe al piacere e all’unione con la donna amata. L’assenza del riflesso nello specchio, d’altro canto, è un forte elemento di disturbo e di terrore sia per il protagonista che per la contessa; è l’altra faccia della medaglia. Balduin, nel tentativo di liberarsi del suo riflesso che lo perseguita, “afferra l’arma e spara al fantasma, che scompare di colpo. Il giovane scoppia in una risata liberatoria ritenendosi ormai al sicuro da ogni tormento…in quello stesso istante avverte un acuto dolore sul lato sinistro del petto…si rende conto di essere stato colpito. Un attimo dopo crolla a terra, morto (p.14)”. Nell’analizzare questo film Rank si sofferma sul fatto che il passato è un qualcosa dal quale non si può sfuggire. Il passato è rappresentato dal riflesso che prende vita e che diventa come un’altra persona. Rank si rende conto che l’idea portata avanti nel film è molto presente nella letteratura del Romanticismo e riprende e analizza le caratteristiche di alcuni famosissimi protagonisti di racconti e romanzi di quel periodo storico. Peter Schlemihl di Chamisso (1781-1836) che vende la propria ombra al diavolo in cambio della ricchezza, L’Horla di Maupassant (1850-1893) nel quale il protagonista cerca di sconfiggere questo essere invisibile, L’Horla appunto, che si rivelerà essere lui stesso, Dorian Gray di Oscar Wilde (1854-1900) che esprime il desiderio di vendere la sua anima in modo che sia il quadro e non lui a invecchiare, William Wilson di Edgar Allan Poe (1809-1849) che si trova a relazionarsi con un suo sosia che si scoprirà essere lui stesso, oppure Il Sosia di Dostoevskij (1821-1881) nel quale viene narrato il rapporto e la persecuzione tra il protagonista Goljadkin e il suo sosia (lui stesso). Questi sono alcuni degli esempi che Rank utilizza per parlare del doppio, a partire dalle formulazioni presenti in letteratura. Rank si sofferma sulle personalità, difficoltà e storie di vita degli scrittori per cercare di comprendere l’humus che possa avere spinto a un’attenzione così forte nei confronti del doppio. Si chiede quale possa essere la cifra comune tra tutti questi autori perché si rende conto che il doppio, al di là delle differenze individuali tra gli scrittori, parla di qualcosa che riguarda tutti e che può essere generalizzato. Collega il tema del doppio a quello del narcisismo, Dorian Gray può amare in modo così smisurato sé stesso e la sua immagine perché contemporaneamente proietta ciò che lo spaventa sul quadro che invecchia al suo posto, il suo doppio. Le parti che vengono rimosse finiscono sul doppio. Alla rimozione, secondo Rank, è collegato “uno sconfinato terrore della morte (p.96)”. La morte, intesa come tentativo di eliminazione del doppio, viene vista come strenua difesa del proprio Io e del proprio narcisismo. Uccido l’altro, cioè me stesso, per lenire l’angoscia legata alla perdita dell’Io. Il doppio parla della paura del soggetto di guardarsi, di mettere in relazione sé stesso con la realtà perché questo potrebbe portarlo alla perdita. Il doppio porta così alla pulsione di morte, al perturbante, ma anche alla pulsione di autoconservzione, alla coazione a ripetere, tutti aspetti che sono stati approfonditi da chi si è occupato di studiare la teoria del doppio a partire da questo scritto di Rank. Funari (1986) nel suo scritto “Il Doppio. Tra patologia e necessità” amplia il pensiero di Rank all’interno del contesto clinico mostrando come “la comparsa del doppio nella situazione analitica, proprio perché legata alla sofferenza psichica, scopre la sua natura di fenomeno-ponte tra un mondo fantasmatico pre-oggettuale e il mondo delle molteplicità oggettuali”.
Condividi questa pagina:
Centro Veneto di Psicoanalisi
Vicolo dei Conti 14
35122 Padova
Tel. 049 659711
P.I. 03323130280